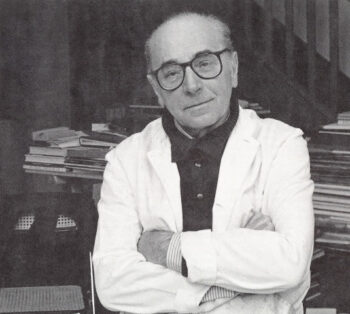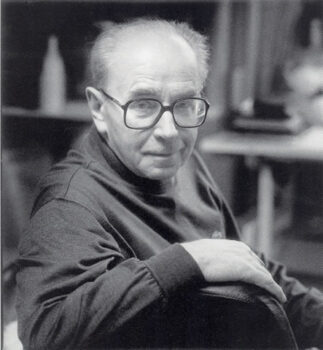JIŘÍ KOLÁŘ SI PRESENTA DA SÉ
”Sono nato in guerra.
Oggi (1969) ho 55 anni, ho scritto dieci libri e da oltre dieci anni faccio collage.
A 35 anni mi sono sposato.
Nel 1953 sono stato imprigionato, ma rilasciato presto. È stata per me un’esperienza decisiva.
Ho capelli grigi, occhi grigi. Ho il respiro pesante e un’andatura pesante. Ma sono allegro e rido volentieri.
Ho cambiato spesso mestiere. Ognuno di questi mestieri mi ha lasciato qualcosa.
Naturalmente amo i libri e tutto ciò che ha a che fare con l’arte moderna.
Del resto l’arte moderna ha influito parecchio su di me. Il mio interesse in proposito risale a quando andavo a scuola.
Mi attirano le grandi città. La vita e soprattutto le persone mi affascinano.
Frequento regolarmente i caffè e ho continui contatti con i miei amici. Ho molti amici.
Le amicizie non mi hanno mai deluso.
C’è da sperare che tutto continui così fino alla fine dei miei giorni. Ciò che mi inquieta di più è il mio lavoro.
Ho ancora tanti progetti che non so se basterò a tutto.
JIŘÍ KOLÁŘ. IL SENSO E IL GIOCO
”Nel quotidiano processo di conoscenza del mondo – al pari di ogni altro sforzo, per esempio quello orientato alla conoscenza scientifica – l’arte può aver luogo solo come elemento costitutivo all’interno di una ricerca più complessiva. Per questo motivo nell’arte non c’è posto per gesti arbitrari, per un nuovo e imprevedibile inizio o una continuazione, bensì soltanto per un inizio e per un procedere che muovono già dal fondamento della natura stessa dell’arte.
Analogamente, nella scienza niente si origina da sé, ma soltanto a partire da ciò che è fondato nella natura di una disciplina particolare (per esempio nella matematica). Ovviamente in ogni caso dipende dalla rispettiva modificazione delle cose. Senza queste modificazioni ogni processo creativo risulterebbe insensato. Ma fondamentalmente non è possibile inventarsi alcunché di assolutamente nuovo…
Ogni nuova acquisizione – nell’arte come nella scienza – amplia il campo della percezione e della conoscenza umana. Questo fattore noetico è per me decisivo e vale anche per quanto riguarda i rispettivi concetti della cosiddetta “bellezza”, con i quali lavorano alcuni esteti. Il perfezionamento della bellezza implica l’ampliamento dell’intero campo della conoscenza estetica.
La nascita di una nuova concezione dell’arte amplia l’intero campo della conoscenza umana. Certo, anche oggi è possibile eseguire un “bel” ritratto, ma Leonardo ha portato quest’arte alla sua perfezione. Van Eyck è riuscito a trasportare questa perfezione a tali altezze da rendere poi necessario un altro modo di procedere. Già Rembrandt recede da ogni forma di idealizzazione. Picasso arricchisce la sua pittura mediante gli impulsi dell’arte primitiva, dei disegni infantili e da cose del genere.
[…] Fin dall’inizio mi sono posto il compito di trovare un punto di contatto tra le arti figurative e la letteratura. Tutti i tentativi precedenti in questa direzione mi sono sempre sembrati poco accettabili e soprattutto non sistematici. Anche se in alcuni casi, per esempio nel caso di Marinetti, essi hanno raggiunto notevoli livelli di sviluppo, essi contenevano sempre un residuo afferente a un’estetica passata. Stesso discorso per Apollinaire. È interessante notare che il lavoro cominciato in questo ambito da Mallarmé sia stato piuttosto recepito da altri poeti, per esempio Eliot, che con la sua Terra desolata – da me ritenuta per questo motivo una delle principali opere della poesia moderna – ha realizzato praticamente un collage. Nel campo della prosa è stato Joyce, nell’Ulisse, a esercitare in un determinato momento del mio periodo poetico una certa influenza, e l’ha fatto proprio mediante il suo modo di articolare i diversi piani della realtà, non avendo paura di ibridare la lingua letteraria con l’argot e il linguaggio dei romanzi da quattro soldi.
[…] Proviamo a riflettere su quanto sia progredita la storia dell’arte poetica. Ogni tentativo di trasformazione o di rivoluzione non avviene per caso. Anch’io ho fatto esperienza traducendo la poesia americana o acquisendo alcuni elementi della tradizione europea. Così un giorno ho capito che sebbene Apollinaire abbia sostituito la parola con l’immagine e Breton con l’oggetto, la loro carica innovativa era comunque ridotta e la loro opera poggiava ancora sulle poetiche tradizionali. Breton non ha mai realizzato un intero verso mediante l’uso di oggetti e c’era bisogno di conoscere il francese per comprendere il significato della parola sostituita. Si trattava comunque del primo passo verso la nuova poesia, sebbene inconsapevole. I surrealisti non si facevano domande sulla natura dell’arte poetica, erano troppo abbagliati dalle loro scoperte e il fuoco fatuo della libertà. Essi riuscirono a rendere libero il loro lavoro, ma si scordarono che questo ha bisogno di regole. Realizzarono la propria libertà estetica, ma fecero in modo che gli altri artisti non venissero considerati semplicemente artisti o persone, quanto piuttosto individui che non capiscono niente d’arte e persino dei criminali macchiatisi della colpa di non condividere la medesima impostazione surrealista. E questo atteggiamento è continuato fino ad oggi. Questa intolleranza è in realtà comprensibile, ma rappresenta anche una delle principali note negative dell’arte moderna. Io capisco che Breton non fosse in grado di apprezzare Mondrian, ma è possibile chiedersi chi tra i due abbia realizzato di più. Alcuni considerano Mondrian un pittore meraviglioso, capace di rappresentare il mondo in modo ordinato e di opporsi all’idea di renderlo ancor più mostruoso di quello che già è. Per me si trattava di capire chi avesse ragione: chi scorgeva nell’uomo una visione tratta dall’Inferno dantesco, oppure chi – come Mondrian – vedeva nel mondo una grande costruzione regolare, la cui origine forse è da rintracciare nella Deposizione di Giotto.

[…] Io penso che tutto sia un prodotto della parola. Indipendentemente dall’origine o dal significato primitivo che ha avuto, una parola costituì l’inizio dell’intera frase e con ciò dell’intero linguaggio. Non senza motivo nella Bibbia si legge: “In principio era il verbo”. E io penso anche che la lingua sia insostituibile, solo per il fatto di rappresentare la forza trainante dell’espressività. Bisogna infatti distinguere tra l’esprimersi e il parlare. Non appena l’uomo comprese questa differenza, subito gli fiorì in bocca il primo verso, la prima comunicazione e, ancor di più, la prima domanda.
Per il poeta la lingua rappresenta una modalità di comprendere o di non comprendere le cose. E spesso, da questa mancata comprensione – dalla quale si origina quello che io chiamo uno scontro, un duello con il linguaggio – può scaturire un verso. Ciò vuol dire: qualcosa che non è linguaggio consueto; qualcosa che sposta i confini del linguaggio, che lo arricchisce. Noi ampliamo il nostro ambito conoscitivo mediante il linguaggio, mediante il semplice parlare abbiamo invece la possibilità di chiarire i problemi o di renderli ancora più oscuri. Ma un problema che diventa oscuro può darci l’impulso a riprendere nuovamente in mano la questione, a vederla in modo diverso; parimenti, un chiarimento accresce sia ciò che sapevamo, sia la sua modalità conoscitiva. È il linguaggio a determinare questo duplice accrescimento. Senza dubbio il linguaggio ha la sua propria storia e il proprio sviluppo. Il suo status attuale è contrassegnato a mio avviso dall’intreccio della lingua con altre percezioni e nuove cose. Cosi si originano nuove parole, che si adeguano a nuove sensazioni.
La lingua parlata (Umgangssprache) si distingue da quella poetica all’incirca come una sorgente si distingue da una conduttura idrica. In entrambi i casi scorre dell’acqua. La lingua parlata assomiglia però a una sorgente impetuosa, mentre nel caso di una conduttura idrica è possibile regolare il flusso a piacimento. Posso bere, se ne ho voglia o ne provo la necessità. Dalla sorgente sgorga acqua in continuazione e questa è a disposizione di ognuno, in ogni momento. Un poeta procede in modo diverso. È lui che regola il rubinetto. Qualcuno e qualcosa che è in lui lo apre…Come ha detto una volta Valéry, la poesia è l’arte del linguaggio, posto che con questo termine non si intenda soltanto la parola parlata, bensì la circostanza che fa modo, grazie alla sua mediazione, di comprendere tutto quello che ci circonda. A ognuno di noi, infatti, le cose e gli eventi più diversi possono parlare senza che s’interpongano immediatamente delle parole. Se noi crediamo che il linguaggio sia qualcosa di globale, non soltanto un mezzo d’espressione dell’uomo, se noi pensiamo come un evento possa spesso influire su di noi in modo più penetrante e forte di qualsiasi cosa che venga scritta o detta, se riteniamo dunque che il linguaggio sia qualcosa di più che una parola detta o scritta, allora io concordo con questa affermazione di Valéry.
[…] Sono pervenuto alla distruzione del linguaggio poetico sulla stessa via e per mezzo del medesimo nuovo modo di percepire e di essere cosciente che avevo maturato in altre discipline. Prima di tutto, come già detto, nella musica e nelle arti figurative. Il modo di percepire al quale accennavo significava che io, da quel momento in avanti, non avrei più potuto cercare la poesia nella parola scritta, bensì soltanto solo al di là di essa. Questo voleva dire la ricerca di un linguaggio nuovo, più vivo.
[…] In un certo periodo ero convinto che ogni poesia dovesse possedere la propria forma. Scrivendo, mi sforzavo di esprimere e sottolineare questa convinzione. Un pensiero che mi ha accompagnato a lungo, persino nella fase iniziale della “poesia evidente”. In una delle sue fasi ha cominciato, infatti, a sfuggirmi in un certo senso la chiara comprensibilità delle mie poesie. Soprattutto a proposito degli “analfabetogrammi”, le poesie-oggetto, le poesie-immagine e le poesie-cromatiche. Senza un ordine chiaramente fissato veniva fuori sempre qualcosa di troppo caotico, qualcosa insomma di più simile a un collage che a una poesia. Perciò, per concretizzare l’espressione, ho cominciato a usare un sistema “a righe”. Queste poesie risultavano comprensibili, precise come un poema annodato in posizione orizzontale, anche se in realtà il materiale era distribuito in modo complicato sulla superficie. Sperimentai con questo sistema orizzontale le poesie-nodo e le poesie-lametta. Da questo punto di vista è interessante e significativo notare come alcune delle mie poesie-immagine e poesie-circolari (fatte di labbra, occhi, dita ecc.) non abbiano attirato l’attenzione. Ma questa scattava allorché inserivo gli elementi in un sistema narrativo. Doveva rimanere qualcosa, dovevano rimanere le righe. Per le persone era già abbastanza incomprensibile che io volessi comporre dei versi liberi utilizzando oggetti o immagini. Quando ho deciso di voler utilizzare un’altra forma non mi restava che ricorrere al collage. Dovevo tornare alla forma espressiva classica, lineare: riproporre la sequenza dei versi. In alcune poesie-immagine la funzione delle rime era addirittura assolta dai diversi colori. Per me si trattava, come sempre, di suggerire un nuovo modo di percepire le cose, non tanto di far leggere qualcosa.
[…] Ogni scrittore sa cosa vuol dire comporre tre, quattro versioni di un testo per poi buttare i tentativi falliti nel cestino. Anche a me una volta è successo lo stesso. Non appena misi un foglio nuovo nella macchina da scrivere pensai se la versione che avevo fatto – quella finita nel cestino – non fosse ancora utilizzabile. Dopo averla recuperata e aver cercato di togliere qualche piega dalla pagina, subito afferrai che cosa mancava a quel testo: le tracce dell’accartocciamento. Come stregato estrassi il foglio pulito dalla macchina da scrivere, lo accartocciai e dopo averlo stirato con le mani rimasero delle grinze: davanti a me c’era un foglio bianco, ricoperto da una scrittura sconosciuta. Forse si trattava della scrittura del fallimento, forse di quella della rabbia. Comunque: era una bella scrittura. E così è cominciato tutto. Prima un foglio bianco, poi uno nero, scritte, note musicali, un’incisione, una riproduzione. Un accartocciamento non riesce bene a secco. La carta deve essere ben impregnata e non può essere lavorata a lungo. Bisogna agire in modo rapido ma con sensibilità, e il risultato è sempre incerto da definire, essendo sempre figlio del caso. Le correzioni sono possibili in minima parte, in quanto il foglio tende facilmente a strapparsi e il lavoro deve essere finito in fretta. Il senso di questa operazione lo può cogliere chiunque. Penso che ognuno di noi abbia fatto esperienza di questi momenti, quando qualcosa di intimo si spezza eppure – volens nolens – si tratta di continuare a conviverci. Ognuno di noi non porta forse in sé una piccola rovina? È possibile poi definire con precisione se distruggere significa parimenti l’inizio di qualcosa di nuovo?
[…] Ho scritto poesie nelle quali costringevo il lettore a confrontarsi con se stesso. Oppure gli lasciavo lo spazio di muoversi liberamente. Sceglievo oggetti “dimostrativi”, che potessero costringere il fruitore a osservarli da più parti, a scegliere un lato e a guardarli come si farebbe con uno specchio, sollevandoli o manipolandoli in altro modo. Non si trattava solo di un gioco. Volevo coinvolgere l’osservatore, fargli fare qualcosa, sebbene l’oggetto avrebbe dovuto risultare autonomo anche senza questa attività.

[…] Sono sempre stato interessato a riviste e giornali, non a causa della loro forma, ma in generale; soprattutto nel dopoguerra, allorché ogni cosa si rivelava per me eccitante. Già il fatto che un quotidiano non può mai essere fatto, per così dire, con un giorno di anticipo. Questa incapacità di prevedere le cose fece sì che io cominciassi a tenere un diario. Non dovevo soltanto seguire quello che accadeva nel mondo, ma in generale ciò che si svolgeva intorno a me, dentro di me, e il modo con il quale io riuscivo a entrarci in relazione. All’inizio provai con la poesia e con la prosa. Anche il successivo impulso, mediante la composizione di collage con testi stampati o scritti, era motivato allo stesso modo. Così mi allontanai sempre di più dal principio del vecchio collage, che adesso ritenevo inadatto al mio lavoro. Il “cosa” era quindi determinato dal tempo, e il “come” scaturiva in qualche modo dal “cosa”. Il Giappone agiva su di me in maniera molto diversa dall’America; quello che accadeva a Parigi in maniera diversa da quello che accadeva a Praga. E tutto ciò implicava una diversa elaborazione formale sulla superficie. Si trattava di un lavoro bello e avvincente. La formazione di un diario è dovuta soprattutto all’effetto degli eventi sugli uomini. Si acquistano diversi biglietti di ingresso, tessere di viaggio, roba di ogni genere, ti capita per le mani la corrispondenza quotidiana, anche un annuncio mortuario. Non si può mai sapere quello che il giorno ci porterà. Una volta accumulato tutto, lo si distribuisce in qualche modo sulla superficie, secondo un’intuizione compositiva guidata dalla propria esperienza. Ecco quello che io ho chiamato “poesia dimostrativa”. Proprio questa cosa imprevedibile, portata dal giorno, assumeva il carattere di una testimonianza della mia giornata.
Migliaia di eventi entrano nella nostra vita, l’attraversano e scompaiono, consegnandoci comunque qualcosa che prima ci sembrava inessenziale. Spesso mi sono accorto che un dettaglio era rimasto come impigliato nella memoria, e ancora più frequentemente ho preso a interessarmi dell’aspetto tecnico. Come una cosa era scritta o era fatta. Se si trattava di un’immagine ciò che mi colpiva era sempre la struttura, piuttosto che il contenuto aneddotico. Non ho mai pensato che la cosa interessante, per esempio in un quadro di Pollock, fosse per l’appunto questo tipo di contenuto: quello che mi colpiva era come le sue opere erano fatte.
[…] La cosa che più mi ha interessato era sempre l’effetto delle cose sull’uomo e quello dell’uomo sulle cose. Tutta la mia attività si è concentrata su questo: liberare le cose dallo schema del loro significato simbolico convenzionale. Non ho mai sopportato la pretenziosità con la quale si è sempre voluto caricare l’attività simbolica. In questo modo quello che andava perso era il significato autentico delle cose. Nonostante sia una tendenza ormai vecchia di alcuni millenni, noi accettiamo sempre questa impostazione e sembriamo incapaci di guardare oltre. Proprio per questo è così difficile modificare il mondo. Se noi abbiamo parlato però della purezza delle cose, allora le cose non dovrebbero essere oscurate dal loro significato simbolico. Le cose devono essere lasciate così come sono, altrimenti possono originarsi operazioni arbitrarie di ogni tipo, per esempio come quelle effettuate dai surrealisti, per i quali (sebbene come surrogato) una cravatta simboleggia un cappio o l’organo genitale maschile: un esito decisamente insensato. Io non affermo che nell’arte non ci debba essere alcun posto per questo tipo di operazioni, ma dal mio punto di vista lo ritengo comunque un modo di fare arbitrario e ho sempre cercato di contrastarlo.
[…] Ogni cosa che entra in nostro possesso è attratta dall’orbita del nostro destino. E questo si manifesta con tanta maggiore evidenza, quanto più profondo risulta l’effetto di una cosa sulla nostra vita. Anche le cose vivono e invecchiano insieme a noi, dipendono dalla nostra esistenza, dalle nostre esperienze e dalle modificazioni del nostro destino. Essendo scrittore, io riesco a scorgere il destino che si nasconde nelle cose. C’è stato un tempo nel quale ho persino provato a decifrare in che modo certi oggetti si sarebbero evoluti: con chi sarebbero entrati in contatto, che tipo di vita avrebbero condotto…e un giorno m’è venuta voglia di rendere visibile questa scrittura fatta di graffi e di relazioni umane. Cominciai a incollare le cose, le mie poesie-oggetto. Picasso è stato il primo artista moderno a comprendere l’essenza umana delle cose. Un po’ come se attribuisse loro una coscienza. Per questo motivo ha potuto pronunciare belle e sagge parole sul suo amore per le cose e sulla coesistenza delle cose nei suoi dipinti. Picasso è stato anche il primo a comprendere che le cose possono parlare tra loro. All’improvviso si scopre che alcune cose riescono a dialogare, mentre altre no. E quelle che non ci riescono bisogna lasciarle riposare le une accento alle altre per lungo tempo, in modo che ci possa abituare a loro, che loro stesse si abituino a stare vicine. Potrebbe sembrare un’esperienza mistica, eppure è così. Dobbiamo instaurare un rapporto tra noi e le cose, in questo modo, grazie alla nostra mediazione, le cose stesse riescono a trovare se stesse.
All’inizio degli anni Cinquanta ho lavorato con la fotografa Eva Fuková all’idea della fine delle cose. Ogni momento non muoiono solo migliaia di uomini, ma anche milioni di cose. Alcune muoiono lentamente, altre improvvisamente. Altre ancora sopravvivono al loro destino sotto forma di rovine e io penso che su un tema come questo si potrebbe comporre uno studio o scrivere un libro. Dopo la mia malattia (nel 1970) ho dovuto imparare da capo molte cose, ricominciare nuovamente a pensare, a pensare in modo nuovo, compiendo una rivoluzione profonda all’interno della mia coscienza. Quello su cui mi ero arrovellato così spesso e che fino allora mi era risultato difficile da comprender improvvisamente ha dischiuso il suo senso. Il passato si è fuso con il presente, la finzione con la realtà, la fantasia con la percezione della realtà e tutto secondo un’intensità particolare. Ancora una volta sono stato costretto a ricordare a quei tempi passati, nei quali non pensavo che dietro a ogni cosa si nascondesse qualcosa di eccezionale, di notevole, e un albero, una casa, un fiore, una pietra, il sole, una sedia, i pensieri mi diventarono improvvisamente sotto un’altra luce familiari. Potevo dialogare con loro, dar loro del tu, potevo offenderli, amarli o temerli. Il tempo si era unificato. Lo spazio aveva perso la sua estensione, la prospettiva annullata o capovolta, come se mi trovassi davanti a qualcosa di molteplice e caotico. Questi erano i miei pensieri e le mie sensazioni, in quel periodo.se un tempo ero stato impressionato dai paesi che avevo visitato – con i loro aspetti terribili, le loro bellezze, la loro speranza, la loro libertà – adesso non c’erano cose che non mi colpissero profondamente. Capivo insomma che non avrei più perso ciò che era sempre stato l’obbiettivo di ogni mio sforzo: la convinzione della sconfinata unità della realtà. E reale era anche la mia condizione irreale. Cominciai nuovamente ad apprendere il mio lavoro. Tenere in mano le penne, strappare un piccolo frammento di carta, parlare. Sentivo come le mie facoltà si moltiplicavano e il mio stesso disfacimento. Avevo infatti acquisito il potere di osservarmi. La mia testa riempiva improvvisamente tutto lo spazio. Le mie membra crescevano in direzioni impensate. Tutto acquisiva dimensioni gigantesche. E colui il quale possiamo chiamare forse Dio, e che io stesso chiamo Dio, ha infine esaudito le mie preghiere. Non potrei esprimerlo altrimenti. Cosa sarebbe potuto accadere dopo? Non avevo mai lavorato così privo di impedimenti, di ostacoli, non mi ero mai sentito così libero. Ammesso che in passato avrei avuto paura di non riuscire a concludere un lavoro, adesso non avevo più paura. Lo so, sono pazzo. Ma non è forse pazzo anche questo mondo pericoloso nel quale viviamo? Questo mondo ha forse un senso? Non importa: non c’è niente, ora, verso cui io provi indifferenza. Forse il fatto che io ancora viva ha un senso. Che niente mi è indifferente, questo è il senso.